In un pomeriggio di settembre del 2005, nel cuore delle montagne del Pakistan, due alpinisti arrivati dall’America completano un’ascensione che fa storia. Steve House e Vince Anderson, con la lentezza delle altissime quote, escono da una delle pareti più grandi e pericolose della Terra. Un passo dopo l’altro, si avvicinano agli 8125 metri del Nanga Parbat, una vetta che è un mito dell’alpinismo mondiale.
In cinque giorni di arrampicata in stile alpino, Vince e Steve hanno tracciato una via nuova sulla parete Rupal, la più alta e ripida della montagna. Quando arrivano in cima le cinque del pomeriggio sono passate da un pezzo, e l’ombra del Nanga inizia a riempire le valli. Si abbracciano, e non trattengono il pianto.
“Lacrime ghiacciate scivolano ai miei piedi unendosi alla neve, diventando parte di questa montagna, come lei era diventata parte di me tanti anni fa” racconta House nel suo primo libro. “Questo viaggio fisico e mentale di anni – per arrivare a essere abbastanza forte, per scoprire se ho abbastanza coraggio – si chiude qui, in questo istante”.
“Passiamo un quarto d’ora a goderci la vittoria” annota più sobriamente Vince Anderson sulle pagine della rivista Alpinist. Quando i due voltano le spalle alla cima, inizia una discesa pericolosa e difficile, che richiede due giorni e due notti di tensione e fatica.
Alla fine, quando si lasciano alle spalle roccia e ghiaccio, Steve e Vince intravedono al limite del bosco degli uomini barbuti. Pensano che si tratti di Talebani, tentano di scappare, gridano. Invece si tratta dell’ufficiale di collegamento, dell’aiuto-cuoco e di altri due pakistani. Sono venuti ad accoglierli con borracce di tè e biscotti, la tensione si scoglie in una risata. Anche in Pakistan, in anni così difficili, la tensione della parete lascia il posto all’amicizia.
Due anni dopo, quando Steve House dà alle stampe il suo libro Beyond the Mountain (Oltre la montagna nella traduzione italiana) chiede una prefazione a Reinhold Messner, che nel 1970 ha compiuto la prima ascensione della parete Rupal con il fratello Günther, poi scomparso in discesa. L’alpinista più famoso del mondo accetta, e non contiene i suoi elogi.
“Ammiro Steve House per come affronta le montagne. Passo dopo passo è giunto ai vertici dell’alpinismo” scrive l’uomo di Funes. “In un’epoca in cui tutti salgono l’Everest, Steve sale le vie giuste sulle montagne giuste”, “prosegue nel solco di Mummery, Bonatti e Robbins”, “le sue storie evocano in me sentimenti forti”.
Fino a diciott’anni, Steve House è un tipico figlio dell’America rurale. Nato nell’Oregon, scopre la montagna in Europa. Non a Chamonix o a Zermatt come molti connazionali, bensì in Slovenia, tra le Alpi di Kamnik e sulle Giulie. Due anni dopo, i suoi amici sloveni lo coinvolgono in una spedizione al Nanga Parbat, la sua prima esperienza himalayana. Steve accetta di buon grado il ruolo di gregario, porta carichi verso i campi alti, impara.
Negli anni che seguono la sua carriera di alpinista decolla. Diventa guida alpina, inizia ad accompagnare clienti sulle vette dell’Oregon, dello Stato di Washington e dell’Alaska.
La sua prima via nuova importante è First Born, che traccia con Eli Helmuth sul Father and Sons’ Wall, un impressionante avancorpo del Mc Kinley/Denali. E’ una delicata arrampicata su ghiaccio e misto, con cascate verticali, placche rivestite da due o tre centimetri di vetrato e passaggi di dry tooling.
Seguono altre vie nuove, invernali e ripetizioni in tempi da record di vie sia nel massiccio del Denali, sia su eleganti vette delle Rockies canadesi come il King Peak, lo Howse Peak e il Mount Fay. Nel 1995 apre difficili vie di ghiaccio e misto nella valle del fiume Shoshone, in Wyoming, con un campione dell’alpinismo americano come Alex Lowe.
Nel 1996 Steve apre in solitaria Beauty is a Rare Thing, una via di 2300 metri, con difficoltà di 5.8 su roccia e fino a 90° su ghiaccio, sulla Washburn Face del Denali. Scott Backes, che anni dopo diventerà suo compagno di cordata e suo amico, lo definisce su una rivista “la grande speranza bianca dell’alpinismo americano”.
“Ho paura di quello che ho fatto. E’ stata un’avventura totale, dall’esito sconosciuto. Non andrò mai più così lontano, non da solo” annota nel suo diario l’indomani. “E’ stata la salita che mi ha fatto capire che ero bravo” mi racconta vent’anni dopo mentre lo intervisto a Klagenfurt.
Pochi giorni dopo la Washburn Face, però, Steve rischia seriamente la pelle. Attraversa slegato il tormentato ghiacciaio del Nant Blanc, nel massiccio del Bianco. Cade in un crepaccio, si fa male a una gamba, riesce in qualche modo a uscire. Poi si trascina fino al Pronto Soccorso dell’ospedale di Chamonix, e viene cacciato a pedate perché americano.
“Non ho un’assicurazione sanitaria, né i soldi per potermi pagare le cure mediche. Sono stato un vero idiota. Ho avuto fortuna. La gamba destra non tornerà mai più quella di prima. La prossima volta farò più attenzione. E’ sul facile che si muore” riflette in Oltre la montagna.
I dieci anni che separano quella avventura dal Nanga Parbat sono una lunga serie di ascensioni straordinarie. Vette e cascate di ghiaccio in Nordamerica che dicono poco al lettore europeo, exploit in stile tradizionale come la corsa in 27 ore andata e ritorno dal campo-base alla vetta del Cho Oyu. Poi ci sono vittorie su cime straordinariamente eleganti come il K7. Tentativi a vette poco note come il Kunyang Chhish East, o a pareti straordinarie e famose come la Sud-est del Masherbrum o la Ovest del Makalu.
Negli ultimi anni Steve House non lascia l’alpinismo di punta, ma si dedica anche ad altre cose. Tiene conferenze per il pubblico e altre di motivazione per aziende, partecipa a festival e incontri, diventa padre. Insieme ai suoi sponsor, tra i quali Patagonia e le italiane Grivel, La Sportiva e Asolo, lancia il programma Alpine Mentors per aiutare i giovani talenti dell’alpinismo a formarsi. Un altro programma da lui ideato, la Baltistan Education Foundation, paga gli stipendi e le spese di due maestre che insegnano a 45 bambine nel villaggio pakistano di Kunde, e tre borse di studio universitarie per ragazzi e ragazze della zona.
Oltre che un alpinista straordinario, Steve è un uomo carismatico, di idee e di riflessioni profonde. Nel suo cuore, però, si sente ancora e soprattutto un alpinista.
Ti sei formato tra le Rockies e l’Alaska, sei di casa in Karakorum e in Himalaya. Passi qualche mese ogni anno a Klagenfurt, la città di tua moglie, in vista delle Giulie dove hai scoperto l’alpinismo. Cosa sono le Alpi, oggi, per te?
Ho sempre guardato alle Alpi come a un posto dove spingersi verso il limite, e dove salire vie classiche ed estetiche. Ho salito l’Eiger, la Walker e altre pareti famose. Certo, qui è difficile trovare delle belle vie nuove da aprire.
Il tuo rapporto con le Alpi fa di te un americano atipico?
Sì, certamente. La maggioranza degli alpinisti americani, compresi molti dei più forti, si formano sui Tetons e a Yosemite, salgono le vie classiche del Monte Bianco, poi si spostano in Patagonia. Granito, granito, granito. Se visitano le Dolomiti o le Alpi Giulie si trovano a disagio sul calcare, che offre un’arrampicata diversa e dove è difficile proteggersi. I canadesi sono più aperti e meno provinciali di noi.
Tu invece il calcare lo conosci?
Certo, e devo la sua scoperta ai miei amici sloveni, quelli di oggi e quelli di venticinque anni fa. Il Triglav, una gigantesca montagna calcarea, è un simbolo del loro alpinismo e del loro Paese. Tutti lo salgono almeno una volta nella vita, gli alpinisti come il mio amico Marko Prezelj ci tornano decine o centinaia di volte. Esiste una guida dedicata alla sola parete Nord del Triglav! Invece sul Mangart, con le sue vie di alta difficoltà, vanno solo poche cordate.
Come sei arrivato in Slovenia? Ed è vero che hai scoperto lì l’alpinismo?
Sono arrivato nel 1988, a diciott’anni. Eravamo ventidue studenti americani, invitati per uno scambio culturale. C’era ancora la Jugoslavia unita, io sono stato l’unico a finire in Slovenia, forse perché avevo già esperienza di montagna. Era il mio primo viaggio all’estero, avevo in tasca il mio primo passaporto. Ed era la prima volta che prendevo un aereo.
Come te la sei cavata?
Bene, ma non è stato facile. Ero a Maribor, e nessuno lì parlava inglese. In quegli anni la lingua franca dell’Europa orientale era il tedesco, ho imparato lo sloveno da solo.
Prima di partire sapevi dove stavi andando?
Ho dovuto cercare la Jugoslavia sull’atlante, però avevo studiato bene la storia. Da Maribor sono andato a vedere l’anfiteatro romano di Pola, che è grande e bello come il Colosseo. E sono andato a Sarajevo, a vedere il luogo dove nel 1914 erano stati assassinati l’arciduca Franz Ferdinand e sua moglie, scatenando la Prima Guerra Mondiale.
Cosa facevi prima di quel viaggio?
Ero un ragazzo come tanti, vivevo in Colorado, in un posto remoto, dove si usano ancora molto i cavalli. Studiavo, e poi giravo in pick-up tentando di rimorchiare le ragazze. Non ero molto bravo, e questo mi ha aiutato ad appassionarmi alla montagna.
Torniamo alla Jugoslavia. Che situazione hai incontrato al tuo arrivo?
C’era un’atmosfera molto tesa. Tito era morto da qualche anno, il nazionalismo serbo cresceva, Slobodan Milošević stava per andare al potere. Tutti sapevano che la fine della Jugoslavia era vicina, che i vari gruppi etnici si sarebbero separati, e probabilmente scontrati.
Le tensioni interetniche dividevano anche gli alpinisti?
Ma no, l’alpinismo jugoslavo è sempre stato al 100% sloveno, anche nelle spedizioni himalayane. Nel 1979, sulla cresta Ovest dell’Everest, il capo-spedizione era Tone Škarja, in cima sono arrivati Nejc Zaplotnik e Andrej Stremfelj, e poi Stipe Božić e Stane Belak. Nel 1985, nella prima salita dello Yalung Kang, la cordata di punta era formata da Tomo Cešen e Borut Bergant. Tutti sloveni!
Gli alpinisti sloveni erano uniti tra loro?
No, c’era una competizione fortissima tra i club delle varie città per aprire vie nuove sulle Alpi di Kamnik o sulle Giulie. I segreti venivano conservati gelosamente, sugli avversari si mettevano in giro voci e pettegolezzi.
Tra i tuoi amici sloveni, chi ti ha introdotto all’alpinismo?
Ljubo Hansel, del Club alpino di Kozjak, mi ha portato a scalare in falesia e sulle Alpi Giulie, anche d’inverno. Quando Tone Golnar ha iniziato a preparare la spedizione del 1990 al Nanga Parbat, ha proposto di partecipare anche a me. Eravamo in ventuno: diciotto sloveni, un serbo, un croato e il sottoscritto. Ho lavorato per mettere insieme i 1800 dollari necessari.
Com’è andata la spedizione?
Il progetto era di affrontare per una via nuova la parete Rupal, poi abbiamo ripiegato sulla via Schell, che alla fine si sposta sul versante di Diamir. Sono arrivati in cima Jože Rozman e Marija Frantor, la cordata più forte. Un anno dopo, nella prima spedizione dopo l’indipendenza della Slovenia, sono morti tutti e due di sfinimento sul Kangchenjunga.
Tu che ruolo hai avuto?
Ero il mulo della spedizione, ho fatto una quantità infinita di andirivieni, stracarico, tra i campi I e II. Non mi è pesato, ho capito subito che avevo moltissimo da imparare. Da allora la parete Rupal è stata il mio sogno proibito.
Quindici anni più tardi, quel sogno è diventato realtà. Cosa ricordi con più piacere della tua salita al Nanga Parbat?
E’ stata una magnifica esperienza, e mi ha fatto incontrare un vero amico. Anche adesso, con Vince Anderson, ci sentiamo quasi tutti i giorni.
Cosa pensi della via dal punto di vista tecnico?
La parete Rupal è larga dieci chilometri, sono contento di aver trovato e percorso una via ideale e relativamente sicura. E’ un itinerario tecnico ma non estremo, che sulle Alpi potrebbe diventare classico. Siamo saliti slegati per l’80% della via. Al ritorno, per lunghi tratti, siamo scesi faccia a valle. Eccitante, ma non troppo difficile.
La parete Rupal non è molto pericolosa?
Non dappertutto, e sulla nostra via il pericolo è accettabile, le vie in “stile roulette russa” non sono mai interessate. La via sale per un enorme pilastro, a tratti si arrampica proprio sullo spigolo, al riparo dalle scariche. Certo, nella parte bassa i tratti esposti a cadute di sassi o valanghe ci sono. Negli ultimi due giorni di salita abbiamo arrampicato quasi esclusivamente di notte.
La vostra via interseca quella percorsa nel 1970 da Reinhold e Günther Messner?
Non la interseca, ma è abbastanza vicina. In discesa, dopo una lunga serie di corde doppie, abbiamo raggiunto la via Messner e l’abbiamo percorsa per un tratto. Ci ha permesso di perdere quota rapidamente.
Un anno prima tu e Bruce Miller siete arrivati a 7600 metri ma poi lui ha chiesto di scendere. Su pareti del genere non è meglio essere in tre o in quattro? Altrimenti, se uno non ce la fa, l’intera spedizione fallisce.
Forse sì, ma è già difficile trovare un compagno per andare su una parete così, figurati due o tre! Certo, nel 2004, essere più di due sarebbe stato utile. Bruce mi ha proposto di scendere già al campo I, nella ritirata da 7600 metri alla base ho dovuto fare tutto da solo: piazzare gli ancoraggi per le doppie, sistemare i bivacchi, sciogliere la neve, cucinare. Quando sono arrivato alla base ero esausto, non ho più avuto la forza per tentare un’altra volta. Un altro compagno sarebbe servito moltissimo.
Dopo la prima esperienza con gli sloveni al Nanga Parbat, hai partecipato a spedizioni che hanno utilizzato corde fisse?
No. Scendendo dalla parete Rupal, nel tratto in comune con la via Messner, abbiamo trovato delle corde fisse ma ci siamo rifiutati di toccarle. In Himalaya e in Karakorum, ma anche altrove, usarle non è alpinismo. Perlomeno non è alpinismo moderno.
Cosa pensi dei respiratori a ossigeno?
Li rispetto dal punto di vista storico, qualche decennio fa si credeva che fosse impossibile salire un ottomila senza portarli. In realtà già nel 1963, nella spedizione americana alla cresta Ovest dell’Everest, Tom Hornbein e Willi Unsoeld hanno terminato le bombole, e poi senza ossigeno sono arrivati in vetta e sono scesi verso il Colle Sud e il campo-base. Prima di quel momento, i loro apparecchi erogavano un litro al minuto. Oggi nelle spedizioni commerciali ci sono clienti che salgono respirando quattro litri al minuto. Se l’ossigeno finisce rischiano di svenire e morire.
Ti sei formato come alpinista in Nordamerica, sulle Cascades, sulle Rockies canadesi e in Alaska. Quelle ascensioni ti sono servite sulla parete Rupal e nelle tue altre salite himalayane? E in che cosa?
Certo che mi sono servite! Mi hanno insegnato a muovermi velocemente su difficoltà elevate, su qualunque terreno, con o senza corda. Mi hanno insegnato ad andare leggero ma senza dimenticare nulla di fondamentale, e la leggerezza ad alta quota è decisiva. Mi hanno insegnato ad alterare il ritmo sonno/veglia, e a fare delle tirate non stop di 24-30 ore, o anche più lunghe se necessario. Mi hanno insegnato a non allentare mai la tensione, il minimo errore su pareti del genere può essere mortale.
Hai compiuto alcune delle tue salite più belle in solitaria. Per necessità o per scelta?
Per me decidere di andare da solo o con un compagno è come scegliere un elemento dell’attrezzatura: una corda, uno zaino o un paio di ramponi invece di un altro. Arrampicare da solo ti dà rapidità, e sicurezza dove possono cadere pietre o slavine. Per altri versi, ovviamente, sei meno sicuro. Ci penso, valuto, e decido razionalmente cosa fare.
Cosa pensi dell’alpinismo del futuro? Restano ancora dei veri problemi da risolvere, in Himalaya, in Alaska o sulle Alpi?
Ogni generazione nella storia dell’alpinismo ha dovuto reinventare sé stessa, perché la generazione precedente ha detto “scusate, i problemi sono tutti stati risolti”, e invece non era affatto così. Per me un alpinista è come un pittore di fronte a un paesaggio. Il quadro d’insieme è quello, ma sei tu a dover scegliere cosa mettere in evidenza, facendo passare da lì la tua via. La creatività è una componente fondamentale dell’alpinismo!
A parte il Nanga Parbat, hai aperto i tuoi itinerari più difficili e belli su cime poco note ma sempre molto eleganti. Gli “ottomila” non ti interessano?
Beh, sul Cho Oyu sono salito e sceso dal campo base alla vetta in 27 ore… Però è ridicolo scegliere le proprie mete in una lista bloccata, escludendo le cime a cui manca un metro per arrivare alla quota minima richiesta. Secondo me, il mio contributo più importante all’alpinismo è stato individuare e risolvere dei problemi importanti, su cime poco note e molto belle. C’è anche una differenza di costi. Il K7 è una montagna pazzesca, ma il permesso costa solo 400 dollari, e per salire al campo base basta un giorno. Il K2 o l’Everest richiedono dei budget ben diversi.
In queste salite il tuo alpinismo himalayano si avvicina a quello che hai sempre praticato in Canada o in Alaska. O no?
Direi di sì. Le Rockies canadesi e le montagne dell’Alaska offrono due approcci diversi. Le prime sono simili alle Alpi, roccia è spesso ottima, ci si arriva in un weekend. In Alaska tutto è più lontano e complicato, molte salite sono delle vere e proprie spedizioni.
Nel tuo palmarès ci sono vie nuove ma anche ripetizioni, come la Slowak Direct del Denali (2000) e il record di velocità sull’Infinite Spur del Mount Foraker (2001), un capolavoro di Alex Lowe. Davvero non ti importano le vie nuove?
Mi importano, ma non ne sono ossessionato. Ripetere un grande itinerario come quelli che hai citato, in stile alpino e in poco tempo, mi dà altrettante soddisfazioni.
Parliamo del Pakistan. Prima della parete Rupal ci sono stati lo Hajji Brakk e il K7.
Lo Hajji Brakk, 6096 metri, è una cima inviolata nella Charakusa Valley, che ho salito in solitaria nel 2003 e dedicato al mio portatore Ghulam Rasul e al suo pellegrinaggio alla Mecca, che i musulmani chiamano Hajj. Poco dopo ho tentato per la prima volta il K7. Sono arrivato in cima un anno dopo.
Intanto c’era stata la parete Nord del North Twin
Si, una salita magnifica. Una nuova variante, in condizioni invernali, con il mio amico sloveno Marko Prezelj. Grandi difficoltà, roccia e ghiaccio verticali, bufere. Come sulla Slovak Direct del Denali, come sul K7, per sopravvivere bisognava passare dalla cima. Durante un bivacco mi è caduto lo scafo di uno scarpone, ho dovuto continuare agganciando gli sci alla scarpetta interna, fasciata con una busta di plastica. Dopo la discesa, ho dovuto abbandonare gli sci e camminare.
E poi il K7, la montagna perfetta.
Sì, una cima di 6934 metri, incredibilmente bella e complessa. L’ho salita da solo nel 2004, per una via nuova di 2400 metri, sulla parete Sud, in meno di 42 ore tra andata e ritorno. Era il mio settimo tentativo, dopo mi sono sentito in pace con me stesso. Completo.
Non è stato difficile, dal punto di vista psicologico, tornare per tre volte nella zona, e tentare la salita sette volte?
Certo che lo è stato. Però ogni volta sono arrivato più vicino alla cima, perché ogni volta ho imparato qualcosa di nuovo.
Poi è arrivato il Nanga Parbat, seguito da altre grandi salite. Insieme a Colin Haley hai aperto una via sulla Emperor Face del Mount Robson, la cima più alta delle Rockies canadesi.
Una salita complicata! Per evitare ventisette chilometri a piedi, e di passaggio sotto alla seraccata del Mist Glacier siamo saliti allo Helmet-Robson Col in elicottero. Il primo giorno abbiamo aperto la via, quasi interamente su ghiaccio. Nei tiri finali, che abbiamo valutato M7, la parete era quasi verticale, negli ultimi trenta metri strapiombava.
E poi?
Siamo usciti sulla Emperor Ridge alle dieci di sera, abbiamo bivaccato per qualche ora, poi traversato la parete Sud e siamo arrivati in vetta superando i cavolfiori di ghiaccio della Wishbone Arete. Siamo scesi per la Kain Ridge, in tutto abbiamo impiegato 36 ore. Più la discesa del giorno successivo per il Robson Glacier e una interminabile valle. Un esempio di quelle ascensioni a ritmo quasi continuo di cui ti parlavo prima…
Nel 2008 hai tentato la parete Ovest del Makalu, una delle più alte e difficili al mondo.
Sì, ma in tre tentativi non sono mai riuscito a superare i 7000 metri. Peccato.
Se la racconti così manca un capitolo. Nel 2010 sul Mount Temple, nelle Rockies canadesi, sei volato per 25 metri, ti sei rotto sei costole e qualche vertebra, hai avuto due fratture al bacino, hai avuto un polmone collassato. Dopo un anno di riabilitazione sei ripartito per il Makalu…
E’ vero, e d’altronde andare in montagna è la mia vita. Scrivo, tengo seminari e conferenze, ho un sito e un blog, lavoro insieme ai miei sponsor, sono diventato padre da qualche mese, ma resto prima di tutto un alpinista. Lo strumento principale che ho per raccontare il mio alpinismo, e per promuovere i miei valori, restano le mie ascensioni.
Klagenfurt, dicembre 2016.
Trovate questa e molte altre interviste ad alpinisti nel mio libro Incontri ad alta quota, edito nel 2017 da Corbaccio.
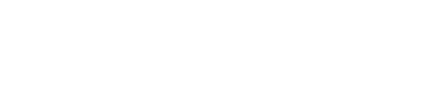

Commenti recenti