Le impressionanti immagini della cresta sommitale dell’Everest, con centinaia di alpinisti in coda verso lo Hillary Step e gli 8848 metri della vetta, hanno fatto il giro del mondo grazie ai giornali, ai siti d’informazione e ai social.
Il commento più diffuso è un paragone con gli ingorghi sulle nostre montagne di casa, dalla via normale del Corno Grande del Gran Sasso fino ai sentieri ai piedi del Catinaccio e delle Tre Cime. Su terreni più impegnativi, ho visto scene del genere sulla ferrata Tridentina del Sella, o sulla pista che sale attraverso il ghiacciaio del Lys verso la Capanna Margherita. I paragoni più calzanti (ma senza il problema della quota!) mi sembrano quelli con la cresta delle Bosses al Monte Bianco, o con la via normale del Castore, un’altra cima del Rosa.
Una volta fatto il paragone, la maggioranza degli appassionati di montagna si affretta a commentare che la vera montagna è un’altra cosa, e che non si metterebbe mai in una soluzione di quel tipo. “E’ la morte dell’alpinismo!” hanno scritto in molti. E non hanno sbagliato di troppo.
Per capire quella foto, e la situazione che c’è dietro, bisogna guardare al business. Ognuno dei clienti nella foto (tra i due terzi e i tre quarti del totale, direi), per essere lassù, ha pagato circa 50.000 dollari, più un’infinità di extra. Il Nepal è un paese povero, e su quella cresta di neve si accalca, tremando di paura e di freddo, una buona percentuale del suo PIL.
Da qualche anno, i responsabili delle spedizioni commerciali tentano di distribuire le salite su più giorni, ma quando le finestre di bel tempo sono brevi nessuno vuole rinunciare alla sua chance di successo.
L’affollamento la lentezza, ovviamente, creano un pericolo grave. Gli incroci sulla cresta e sullo Step sono difficili, l’ossigeno nelle bombole finisce, stare fermi intorpidisce e rende meno reattivi. “Penso con orrore alle sottili corde fisse, su cui si agganciano contemporaneamente decine di jumar” scrive sul suo blog Alan Arnette, il più attento cronista dell’Everest.
Negli ultimi due giorni, 5 alpinisti hanno perso la vita su quella cresta. Ma potrebbe accadere di peggio. Nel 1996 la tempesta raccontata da Jon Krakauer in “Aria sottile” ha ucciso 8 persone, e ha rovinato la vita di molte altre a causa di congelamenti e amputazioni.
Con un affollamento come quello di questi giorni, l’effetto del maltempo potrebbe essere analogo a quello delle valanghe che hanno spazzato nel 2014 e nel 2015 (quest’ultima dopo il terremoto) l’Icefall, la seraccata del versante nepalese. Gli incidenti degli scorsi mesi sul Nanga Parbat o sulle Rockies canadesi hanno indotto qualcuno ad dire che si trattava di un alpinismo suicida.
L’impressione è che il vero pericolo, in questi giorni, sia sulla via normale dell’Everest, dove secondo Reinhold Messner si pratica un “alpinismo turistico di massa”. E’ possibile una soluzione? Si può consigliare ai candidati alla vetta di andare altrove (con 50.000 euro si possono salire molte splendide montagne!), ma il mito del “Big E” è troppo forte.
Il governo del Nepal, negli anni, ha fatto molto per limitare l’impatto ambientale delle spedizioni sul campo base e sulla montagna, ma intasca 10.000 dollari da ognuno di quei signori (e signore), che tremano nonostante l’abbigliamento ultra-tecnico, che fanno la coda a 8700 metri sul mare. Un numero chiuso, con una drastica limitazione degli accessi, ridurrebbe certaamente il pericolo. Ma è lecito dubitare che si faccia.
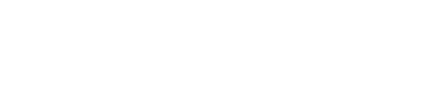

Commenti recenti