I giornali e le televisioni italiane lo hanno completamente ignorato, ma Douglas Keith Scott, in arte Doug, che ci ha lasciato il 7 dicembre, è stato uno degli alpinisti più forti di tutti i tempi.
L’elenco delle sue ascensioni, soprattutto in Himalaya, lascia a bocca aperta. Ancora di più, stupiscono ed emozionano lo stile, la passione per uno stile alpino rigoroso, la serena accettazione di un rischio a volte enorme, ma che era una parte del gioco.
Qualche decennio fa, in Italia e negli altri paesi alpini, l’immagine quasi hippie di Doug, con gli occhiali tondi, i capelli lunghi e la bandana, lo ha fatto prendere poco sul serio. Grave errore. L’alpinista di Nottingham, che avrebbe compiuto ottant’anni tra qualche mese, era una forza della natura, e aveva una tecnica raffinata su qualunque terreno.
Qualche nome? La parete Sud-ovest dell’Everest (1975, spedizione diretta da Chris Bonington), con Dougal Haston, incluso un bivacco sulla Cima Sud. Una via nuova in stile alpino sul Kangchenjunga (1979) con Pete Boardman e Joe Tasker.
La prima assoluta del Changabang e la via nuova sullo Shivling, le cime più belle del Garwhal indiano. Decine di altre salite importanti dal Monte Kenya a Yosemite, e dalla Terra di Baffin all’Arunachal Pradesh, sul confine tra l’India e la Birmania.
E poi naturalmente l’odissea vissuta sull’Ogre, nel 1977, quando Scott si è spezzato entrambe le gambe poco sotto i 7285 metri della cima, è riuscito a calarsi in corda doppia alla base e poi si è trascinato su mani e ginocchia attraverso chilometri di ghiacciaio e morene.
Negli ultimi decenni, si è dedicato a esplorare vette e valli sconosciute dell’Himalaya orientale, ha fondato la ong Community Action, e, sullo stile indicato da Edmund Hillary, è intervenuto più volte a favore della gente del Nepal, soprattutto dopo il terremoto del 2015.
Ho letto per la prima volta di Doug Scott sull’Alpine Journal del 1976, in un lungo articolo dedicato alla parete Sud-ovest dell’Everest. L’ho incontrato di persona due volte, nel 1999 per un’intervista nella redazione di Alp, a Torino, e poi nel 2005 alla Royal Geographical Society, per la celebrazione dei 50 anni dalla prima ascensione del Kangch.
Ho trovato un uomo sorridente, semplice, molto attento alle questioni tecniche dell’alpinismo, durissimo nel difendere un modo di scalare tradizionale e molto “Brit”. Gli ho chiesto “cosa pensa degli alpinisti che sostengono che l’arrampicata sportiva abbia permesso loro di migliorare in montagna?”. E lui ha risposto “è un argomento fasullo”, punto e a capo.
La capacità di accettare rischi calcolati ma enormi univa Doug Scott ai suoi migliori compagni di avventura, e molti componenti di questa straordinaria “Band of Brothers” come Haston, Tasker e Boardman sono morti in montagna. uno di loro, Mick Burke, è scomparso sull’Everest due giorni dopo la vittoria di Scott e Haston.
Chi è interessato può trovare una lunga intervista a Doug Scott nel mio “Incontri ad alta quota”, pubblicato nel 2017 da Corbaccio. Nel mio ultimo lavoro, “Everest”, racconto delle giornate vissute da Doug e Dougal Haston nell’ultimo tratto della parete Sud-ovest.
La meraviglia del tramonto all’ultimo campo, un’arrampicata difficile e pericolosa, lo Hillary Step incrostato di neve, l’arrivo in vetta al tramonto, il gelido bivacco a 8750 metri di quota. Racconta lo stile dell’alpinista e dell’uomo l’ultimo tiro di corda in diagonale della via, tra neve instabile, roccia che si sgretola, chiodi messi a fatica e che si sfilano da soli.
Quando Doug raggiunge Dougal, e prosegue da primo, sibila al compagno “nasty stuff, youth!”, “roba cattiva, ragazzo!”. Tre parole che contengono la voglia di finire una via straordinaria, la consapevolezza del rischio, la fiducia nelle proprie capacità. L’alpinismo.
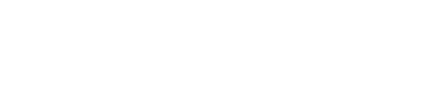

Commenti recenti