Il sentiero che sale all’eremo di San Girolamo e al Monte Fogliano, poco a sud di Viterbo, è tra i più belli della Tuscia. Nello scorso autunno, dopo averlo percorso ancora una volta, ho trovato sulla pagina Facebook di una casa editrice del Lazio un’affermazione sorprendente.
“Una volta raggiunto l’eremo, si sconsiglia di proseguire per il Monte Fogliano se si è sprovvisti della traccia GPX, in quanto il sentiero che collega alla sterrata non è più visibile a causa di recenti cadute di alberi ed è privo di segnavia”.
Era (ed è) una frase senza senso, perché l’obiettivo da raggiungere è una strada pianeggiante, e dal punto dove il sentiero diventa poco evidente basta salire senza via obbligata per 50 o 60 metri di dislivello per trovarla, poco importa se un po’ più a destra o più a sinistra. Il terreno è elementare, perdersi o farsi male è impossibile.
Siamo schiavi delle tracce GPS?
Se racconto questo episodio non lo faccio per prendere in giro gli autori del post e della guida cui fa riferimento. So bene che chi scrive guide può fare errori, e negli anni ne ho fatto qualcuno anch’io. Però credo che quella frase riveli una dipendenza culturale profonda, una sostanziale schiavitù dalle tracce GPS.
E’ un male diffuso ma non diffusissimo, perché sui sentieri incontro centinaia di persone che fanno a meno dell’“aiutino” elettronico. Ed è un errore grave, che può esporre gli escursionisti a seri pericoli. Se la traccia è sbagliata, se il terreno è cambiato o se il tuo aggeggio elettronico si spegne, e non sei capace di orientarti da solo, l’unica cosa che ti resta da fare è una chiamata al Soccorso Alpino. Solo se il cellulare è carico o ha campo, però.
So bene che oggi senza i GPS non si vive. Ne ho visto usare uno per la prima volta più di vent’anni fa, nel Deserto del Teneré, in Niger, e abbiamo trovato subito l’unico pozzo nel raggio di centinaia di chilometri. Senza i GPS si fermerebbero gli aerei e le navi, e sarebbe molto più difficile orientarsi in auto. La montagna e la natura, però, sono un’altra cosa, che qualcuno ha definito il “regno della libertà”.
Mezzo secolo fa, quando ho iniziato ad scalare, mi è stato insegnato che se non passavo in libera potevo tirarmi senza vergogna sui chiodi. Quindici anni dopo, quando esploravo con amici più bravi di me le cascate di ghiaccio della Laga, le piccozze erano legate all’imbrago da cordini, ed era lecito appendersi per riposare.
Sugli “ottomila”, cinquant’anni fa, respiratori e bombole venivano utilizzati da tutti. Ora i clienti delle spedizioni commerciali li usano, e lo stesso fanno le guide che li devono condurre in sicurezza. Per gli alpinisti più forti, però, salire senza bombole è essenziale. Il criterio, dall’Everest fino alle rocce del Lazio, è di rendere tutto più difficile, più naturale, più sportivo.
Sentieri e segnaletica tradizionale
Sui sentieri, però, la “porta” delle attività di montagna per migliaia di nuovi appassionati ogni anno, le cose sembrano andare in senso opposto. La segnaletica è sempre più capillare e precisa. I siti delle aree protette, degli enti di promozione turistica, perfino degli editori di guide cartacee permettono di scaricare migliaia di tracce già pronte. Su alcuni siti non si capisce chi le abbia registrate, né quando, mentre le guide cartacee un autore e una data ce l’hanno. Ma sappiamo che le frane, il cambiamento climatico e i terremoti trasformano continuamente la montagna.
Il Parco Sirente-Velino, in Abruzzo, ha deciso che per camminare sui loro sentieri bisogna aver firmato uno scarico di responsabilità online, e aver scaricato una “traccia”. E’ un meccanismo che credo sia stato creato per la prima volta al mondo (ma perché in Alto Adige o in Svizzera non ci hanno mai pensato? Boh…), che non ho capito se è già pienamente in vigore o meno, che dovrebbe creare sicurezza ma rischia di fare il contrario.
Non difendo il mio interesse corporativo di autore di guide cartacee, che hanno mostrato negli ultimi anni di conservare uno spazio sul mercato. Credo che dietro quest’alluvione di tracce, oltre al legittimo interesse dei produttori e dei venditori di GPS, e al consumismo ben diffuso anche in montagna, ci sia l’esigenza dei soggetti che ho citato poco fa di controllare l’afflusso, di bloccare l’escursionismo “libero”, di evitare responsabilità vere o presunte in caso di incidenti.
L’Italia si è americanizzata, gli avvocati chiedono danni per tutto, “pararsi” per gli enti è la soluzione migliore. La stessa esigenza, sei mesi fa, ha fatto entrare in vigore una legge sull’obbligo di ARTVA, pala e sonda scritta male, e diversa da tutte le norme regionali in materia. Quando il CAI ha chiesto chiarimenti su dove dovesse valere e dove no, lo Stato italiano non si è degnato di rispondere.
D’altronde, nel Paese che vorrebbe imporre la sicurezza a ogni costo sui sentieri, in molte città (tra cui Roma, dove vivo) i vigili urbani e gli altri corpi di Polizia non multano chi viaggia in auto senza cinture, non lega i bimbi a un seggiolino e non si ferma davanti ai pedoni sulle strisce. A Napoli, e in buona parte del Sud, non si fermano i ragazzi che vanno in moto senza casco e rischiano la sedia a rotelle a vita o la morte. Magari qualcuno di loro è stato multato per una ciaspolata senza ARTVA.
Rischio di essere troppo lungo, e mi avvio a concludere. Negli ultimi anni ho soccorso escursionisti che per seguire pedissequamente una traccia sono finiti su ripidi nevai primaverili e hanno rischiato la pelle. Tre anni fa (e tre anni dopo il terremoto di Amatrice) ho incontrato sui Sibillini un camminatore sconvolto, che aveva seguito una traccia pre-sisma attraverso un pendio che era in buona parte franato. Una situazione che avrebbe potuto capire alzando gli occhi dal GPS e guardando quel pendio da lontano.
Pochi giorni fa, sull’unico tratto ripido della salita al Monte Greco, ho seguito un sentierino visibile da un chilometro di distanza, segnato da molti ometti di pietre. Dei ragazzi sono passati più in basso, faticando su una pietraia bestiale. Quando gli ho detto che ero sul sentiero giusto hanno detto “non è possibile, la traccia è qui” e hanno continuato a ravanare.
Potrei continuare parlando con un po’ di fastidio di quelli che dopo ogni gita pubblicano dislivello e tempo su Facebook per sfoggiare il loro allenamento. O di quelli che oltre al GPS portano appesa una radiolina con cui salutano in continuazione i loro amici “Oscar”, “Lima” e chissà cosa sparsi per le montagne, come se stessero pilotando un elicottero o un aereo.
Vorrei chiedere al signore che esplora itinerari impegnativi, pubblica la traccia su Facebook e ci scrive accanto “non per tutti” perché non torna all’antica, scrivendo una relazione, e spiegando le difficoltà da aspettarsi in quei luoghi, come passaggi su roccia o su neve, rischio di scariche o frane, tratti esposti…
Potrei raccontare di quanto mi sono divertito, in passato, cercando sentieri segnati in maniera “alternativa” ed ecologica, come con i sassi incastrati tra i rami nel Supramonte, in Sardegna. Potrei suggerire di leggere gli scritti di Franco Michieli, teorico e grande praticante dell’escursionismo nella wilderness.
Potrei raccontare che chi, come me, ha iniziato a camminare su un’Appennino quasi privo di segnavia ha sviluppato la capacità e il piacere di orientarsi. O potrei dire dei tre GPS che mi sono stati regalati negli anni. Due li ho usati per fare io dei regali (due figuroni!), il terzo è ancora in un cassetto, qui a studio, nella sua scatola intonsa.
Potrei, ma questo merita un altro intervento, tornare su una mia vecchia proposta, di lasciare qualche valle e qualche massiccio libero e senza segnavia, tanto per giocare e imparare a orientarsi. L’ho proposto trent’anni fa per la Laga, e nessuno mi ha ascoltato. Forse oggi, magari inventando un nome esotico (va bene “no paint”?) qualcuno appoggerebbe l’idea.
Potrei, e forse è la cosa più importante, ripetere quello che ho scritto nelle introduzioni di tante mie guide, e cioè che “cercare la propria via, rischiando magari di perdersi, è una delle cose che rendono interessante l’escursionismo”, perché altrimenti si potrebbe camminare su una pista da atletica in pendenza.
Nel mio ultimo libro, che è dedicato al Monte Bianco, ho raccontato degli otto inglesi che nel 1741 sono partiti da Ginevra per Chamonix. Sapevano di andare in una valle sconosciuta e cattolica, temevano chissà quale agguato, e sono arrivati con pistole e fucili spianati. Invece dei nemici è sbucato il parroco, che ha fatto un sorriso e li ha invitati a cena. Gli otto hanno riposto la ferraglia, e l’esplorazione di quella straordinaria montagna è iniziata.
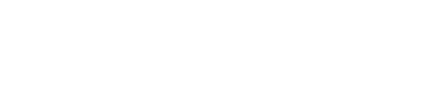

Caro Stefano, come tutte le strumentazioni teclogiche, il ricevitore GPS bisogna conoscerlo, saperlo utilizzare e soprattutto saper leggere le informazioni che trasmette, non ultimo ma di primaria importanza, solo le impostazioni corrette se vogliamo ritrovarci sulla topografica che utilizziamo. Sicuramente ha anche lui dei limiti proprio perché è tecnologico, ma ormai la tecnologia è entrata di prepotenza nelle attività outdoor, consideriamo che oggi la maggior parte degli uscursionisti usa app pressoché simili al gps che molte volte salvano loro la vita in caso di soccorso! (per fortuna) Detto questo, molti utilizzando la tecnologia, purtroppo hanno perso l’ abitudine ad utilizzare un’ altro strumento: “l’occhiometro” Un caro saluto e ti aspettiamo al Gran Sasso Adventure Park.
sempre bravo e conciso.
Mi dispiace che non ci conosciamo molto caro Stefano. Come ho già commentato con Germana io non scrivo più su FB e metto pochissime foto.
Mi sono intristito di come è diventato il popolo di FB con i suoi commenti inutili e arroganti da alpinisti di “primo pelo”.
Noi ci siamo visto poche volte ed ora mi presento; frequentando l’università di scienze agrarie in Ascoli Piceno prima e poi concludendola a Perugia, nei primi anni ’80 frequentavo assiduamente il gruppo ascolano ed arrampicatori di solito con Tito,Tiziano,Franchino ed Alberico.Ma il mio compagno di cordata è stato Tonino Palermi.
Ho omesso volutamente i cognomi perché so la tua amicizia con loro.
Quindi sono cresciuto “alpinisticamente” con la mentalità Ascolana che tu (ripeto) conosci bene.
Non posso che darti ragione sul tuo scritto anche se io sarei stato più duro ( ma non sono un giornalista).
Ancor oggi arrampico ma non più come quei tempi ma quando vado per sentieri è sempre una scoperta soprattutto storica dei luoghi.
Con questo ti saluto sperando di incontrarci da qualche parte.
Ciao Pierluigi
Caro Stefano, è iniziata in Val di Mello l’idea del non racconto, di passare in punta di piedi e di non lasciar traccia neppure sui terribili social …. A Marettimo dove abbiamo percorso un magnifico trek, quando lo percorriamo come guide lasciamo a casa cellulari macchine fotografiche
È un viaggio nella natura selvaggia con la possibilità tutt’altro che remota di perdersi … perdersi fa parte del gioco
Questi luoghi non raccontati, codificati e tracciati sono sempre più rari e vanno salvati con i denti
Le dritte di Stefano Ardito sono magistrali, veritiere e di buon senso: mai aver fiducia in modo esclusivo sia del GPS e della cartina tavoletta militare 1:25000 o anche dei testi tutti possono sbagliare e quindi la migliore scelta è l’interpretazione del territorio in relazione agli strumenti e capacità con discernimento consapevole dell’itinerario più sicuro in relazione alle condizioni meteo ed equipaggiamento. Che dire Stefano Ardito è un professionista di lunga esperienza i miei più fervido saluti.
La sola traccia gps non può e non potrà mai sostituire la conoscenza del territorio, i cambiamenti in natura sono sempre più frequenti e apportano modifiche anche sostanziali ai tracciati dei sentieri, lo strumento gps è un utile strumento che la tecnologia ci ha regalato ma spesso sulle carte gps non vengono riportati dettagli e anomalie del luogo, la conoscenza prima di tutto…la tecnologia sempre a supporto della conoscenza