Stazione di Henley-on-Thames, estate del 1983. Quando scendo dal treno che mi ha portato fin là dalla stazione londinese di Paddington, John Hunt mi saluta in due lingue. “Good morning sir, ha fatto un buon viaggio?” Non sapevo che parlasse italiano, gli chiedo se lo abbia imparato sulle Alpi, a Courmayeur o a Cortina. La risposta mi stupisce di nuovo. “No, ho imparato la sua lingua in Abruzzo”.
Tra il 1943 e il 1944, nelle dure battaglie combattute tra l’Adriatico e l’Appennino mentre l’attenzione del mondo è puntata su Montecassino, il capitano (e poi maggiore) John Hunt comanda dei reparti impegnati tra Lanciano, Pennapiedimonte, Guardiagrele e Casoli. Più volte, ufficiali e soldati al suo comando risalgono i selvaggi valloni della Majella. In alto, sul Monte Amaro e le altre cime, sono asserragliati i militari tedeschi della Wehrmacht.
Il nome di John Hunt, però, diventa famoso a causa di una montagna molto più alta della seconda cima d’Abruzzo. Nell’estate del 1952, dopo il successo della ricognizione britannica del 1951 e il fallimento del team svizzero che non va oltre gli 8500 metri di quota, inizia a nascere a Londra la spedizione destinata a conquistare l’Everest.
Nel comitato organizzatore, il Joint Himalayan Committee, siedono rappresentanti della Royal Geographical Society e dell’Alpine Club. Tutti considerano Eric Shipton, leader della ricognizione del 1951, uno straordinario organizzatore di piccole o piccolissime spedizioni. Molti però hanno dei dubbi sulla sua capacità di gestire un’impresa più complessa.
A luglio John Hunt, che è stato promosso colonnello ed è di stanza in Germania, riceve un telegramma che gli propone di diventare responsabile organizzativo del team. Ad agosto Shipton, di fronte al progetto di una spedizione a due teste, preferisce dare le dimissioni, e Hunt viene nominato leader. “Abbiamo preso la decisione giusta nel peggiore modo possibile” scriverà un componente del comitato.
Hunt viene messo in aspettativa dall’esercito, va a Londra, inizia a mettere insieme il team. Pensa a una squadra tutta nuova, poi invita gli alpinisti legati a Shipton, compresi i kiwi Edmund Hillary e George Lowe. Alcuni si chiedono se partecipare a un’impresa diretta da un militare. “Durante l’intera spedizione John è stato uno straordinario organizzatore” scriverà Hillary anni dopo. “E non posso ricordare un singolo ordine che mi abbia indirizzato in tutto il viaggio”.
Che la spedizione del 1953 abbia avuto successo si legge sui libri di storia. Il 29 maggio 1983 a Pen-y-Gwryd, in Galles, una riunione tra i membri del team celebra i trent’anni da quella straordinaria vittoria. Manca Edmund Hillary, che è ancora una volta nel Khumbu. Mancano Tom Bourdillon, Wilfrid Noyce e Charles Evans, che sono scomparsi da anni. Gli altri componenti ci sono tutti, insieme a un inviato del New York Times. La mia richiesta di assistere all’incontro, spedita per posta mesi prima, è stata accolta con un netto (anche se cortese) “no grazie”. Ripiego su un “piano B” che ho già in mente, una serie di interviste dopo l’incontro ufficiale.
Prima di decollare verso Londra, mi chiedo che senso abbia, trent’anni dopo gli eventi, aggiungere il mio nome all’elenco di chi ha scritto di quella ascensione lontana. Sulla spedizione del 1953 all’Everest sono state scritte dozzine di libri, sono stati girati dei film, si è discusso all’infinito. Anche i bambini, non solo nel Regno Unito, scoprono i nomi di Hillary, Tenzing e Hunt tra quelli dei grandi esploratori del pianeta, accanto a Cristoforo Colombo, a Roald Amundsen e a James Cook.
Ma un po’ di curiosità nella mia mente e nel mio cuore rimane. Curiosità di conoscere volti e storie di un gruppo dove solo Edmund Hillary è diventato famoso nel mondo. Voglia di ascoltare dalla voce dei protagonisti l’entusiasmo del 1951 per la scoperta di una possibile via per l’Everest dalle valli nepalesi del Khumbu, e la delusione dell’anno dopo quando il permesso è stato assegnato agli svizzeri.
Curiosità di mettere a fuoco i dettagli “piccanti” come l’allontanamento di Eric Shipton dal team e la sua sostituzione con Hunt, o come la scelta di una cordata di punta che non comprendeva britannici. O di conoscere le reazioni degli alpinisti al ritorno, durante i festeggiamenti in India e in Nepal, davanti a striscioni e cartelli che mostravano Tenzing issare di peso un Hillary disfatto e boccheggiante.
Nel 1983 il mio viaggio nella storia dell’Everest ha due tappe. A Nottingham, a casa di George Lowe, trovo il racconto di una vita avventurosa (dopo la spedizione all’Everest arrivano il Makalu, l’Antartide, dieci anni di vita e di montagne in Cile), e quello dell’amicizia con Edmund Hillary, l’altro neozelandese della spedizione. A Henley-on-Thames, nell’elegante cottage di John Hunt, ascolto invece i racconti di un lungo e profondo rapporto con l’India e con l’Asia, e di numerose spedizioni esplorative nell’Himalaya del Kashmir e del Sikkim. Scopro una vita che la vittoria sull’Everest ha cambiato, proprio come quelle di Tenzing e Hillary.
Edmund Hillary ha dedicato un’ampia fetta della sua vita al Khumbu e agli sherpa. Sono opera del suo Himalayan Trust i ponti sui fiumi e i torrenti, le scuole dei villaggi sherpa, l’aeroporto di Lukla e il piccolo ospedale di Khumjung. Come ambasciatore della Nuova Zelanda a New Delhi e a Kathmandu, Hillary avvia la collaborazione tra la Nuova Zelanda e il Nepal per la realizzazione del Sagarmatha National Park.
Nella sua casa di Henley-on-Thames, parlandomi dei problemi dei giovani inglesi, John Hunt mi racconta di aver spinto, nei suoi anni alla Camera dei Lord, affinché “molti giovani, in Gran Bretagna, potessero trovare il loro Everest, per piccolo o grande che fosse”. Anche quando gli chiedo dei difficili momenti nei quali, dopo l’allontanamento di Shipton, si è trovato senza esserselo aspettato al timone della spedizione all’Everest, Sir John mi risponde serenamente, e senza peli sulla lingua.
Che giorno è stato, per John Hunt, il 29 maggio del 1953?
Un giorno di incredibile ansia. Avevo accompagnato Edmund Hillary e Tenzing all’ultimo campo, volevo aspettarli al Colle Sud. Ma Charles Evans e Tom Bourdillon erano completamente sfiniti, non potevano scendere la ripida parete del Lhotse da soli. Così sono tornato al campo-base avanzato insieme a loro. Il 29 ero lì, a 6000 metri di quota, ad aspettare. Per sapere com’era andato il tentativo ho dovuto attendere il giorno dopo.
Non c’era modo di mandare un segnale?
Non avevamo radio, al Colle Sud. Il povero Wilfrid Noyce, come stabilito, ha piazzato tra il Colle e l’uscita della parete del Lhotse due sacchi a pelo che formavano una “T”, l’iniziale di top, la cima, e ci si è sdraiato sopra per più di un’ora per tenerli fermi. Quel punto avrebbe dovuto essere visibile da noi. Ma c’era la nebbia, non abbiamo visto nulla.
E il giorno dopo…
Prima di tutto ho avuto una la sensazione di sollievo. Quando il gruppo è sceso per la parete del Lhotse, ho contato gli alpinisti e ho visto che c’erano tutti. Poi sono sbucati sul pianoro, George Lowe ha indicato più volte la vetta con la piccozza. Mi è sembrato che il mondo esplodesse.
Qualche giorno dopo, è esploso davvero. Ve lo aspettavate?
Assolutamente no. Ci aspettavamo eccitazione negli ambienti alpinistici, ma quello ch’è successo ci ha colto di sorpresa. Lo abbiamo capito davvero solo arrivando a Kathmandu.
Dove sono iniziate le feste?
Sì, ma anche i problemi. Su Tenzing c’è stata un’incredibile pressione. Lui era uno sherpa, era nato a Thame, nel Khumbu, ma è sempre vissuto a Darjeeling, in India. Gli indiani lo presentavano come indiano, i nepalesi come nepalese. E tutti cercavano di fargli dire che era stato lui ad arrivare in cima per primo, a tirare su di peso Hillary. Povero Tenzing, non ne poteva più. Continuava a chiedermi “che devo dire?”.
Pete Boardman ha scritto di Tenzing come del “primo asiatico di umili origini che è diventato un personaggio di fama mondiale”. È un’immagine bella, e probabilmente è anche vera. Ma la scelta di inserirlo nella cordata di punta serviva a fare propaganda in India e in Nepal?
No, assolutamente no. Prima di partire dall’Inghilterra avevo deciso di scegliere i membri della cordata di punta solo all’ultimo momento, e così ho fatto. Edmund Hillary andava molto forte, era una scelta ovvia. Dall’inizio della spedizione aveva sempre fatto coppia fissa con Tenzing, che andava come un treno anche lui. Certo, mi rendevo conto che era importante che uno sherpa andasse in cima. Avevo vissuto dieci anni in Asia, l’India è parte di me…
… e il colonizzatore doveva farsi perdonare?
Forse un po’. Ma quel pizzico di “complesso coloniale” che c’era all’inizio dentro di me è sparito in fretta. Tenzing e gli altri sherpa d’alta quota, Annullu e Da Namgyal su tutti, sono subito diventati dei compagni di avventura, una parte del gruppo.
Insomma, in un’epoca di grandi spedizioni nazionali, la grande spedizione britannica alla montagna più alta della Terra non manda in cima nemmeno un inglese. E nessuno protesta?
Nessuno. Certo, qualcuno nelle mie decisioni ci ha rimesso, come il povero Michael Ward…
Il medico?
Sì, ma anche un alpinista molto forte. Era stato con Shipton nel 1951, nella prima ricognizione nel Khumbu, e un anno dopo aveva partecipato alla spedizione al Cho Oyu. Però come medico doveva restare a disposizione degli altri, e non è salito nemmeno al Colle Sud.
E gli altri? Tra gli esclusi qualcuno si è lamentato?
Io ho scelto chi andava più forte, e questo lo sapevano tutti. Poi tenga presente due cose. Primo, che in vetta potevano arrivarci Tom Bourdillon e Charles Evans, britannici purosangue tutti e due. Secondo, che allora il Commonwealth era molto unito, avevamo combattuto e vinto una guerra tutti insieme. Non c’erano divisioni con i neozelandesi.
Però delle divisioni, sia pure d’altro tipo, c’erano state ai tempi della sostituzione dì Shipton.
Devo confessare di sì. Quando il comitato promotore (formato per metà da rappresentanti dell’Alpine Club, e per il resto da uomini della Royal Geographical Society) ha sostituito Eric Shipton con me, alcuni alpinisti che erano stati al Cho Oyu hanno deciso di rinunciare. Poi ci siamo parlati, e loro hanno capito. Già salendo verso Namche e Tengboche il team si è unito. Sull’Everest, ho avuto la sensazione di guidare un incredibile gruppo di amici.
Ma John Hunt conosceva Eric Shipton? Di persona, dico.
Sì, anche se non avevamo mai fatto nulla insieme in montagna. Io nel 1935 dovevo partecipare alla spedizione al versante tibetano dell’Everest, sono stato escluso per un soffio al cuore. Shipton mi è stato vicino, mi ha aiutato.
E poi il grande alpinista ed esploratore è stato sostituito da un oscuro organizzatore.
Non è vero! Un po’ di esperienza himalayana ce l’avevo pure io. Avevo fatto tre spedizioni in Kashmir, e tre nel Sikkim, percorrendo i ghiacciai ai piedi del Kangchenjunga e salendo qualche settemila. Nel 1940 avevo come obiettivo il Pandim, una splendida vetta di ghiaccio e neve ai piedi del versante sud-orientale del Kangch. Stavamo per tentare la vetta quando è arrivato un messaggio da Calcutta. E sono andato in Europa, a fare la guerra.
Torniamo all’Everest, per favore. Perché avevano fallito gli svizzeri nel 1952?
Intanto per un motivo stupidamente tecnico, i loro fornelli funzionavano male. Sulla base della loro esperienza, il mio amico Reginald “Reggie” Cook ha ridisegnato i nostri, che sono andati benone. Anche in alto, al Colle Sud e dintorni, riuscivamo a bere due-tre litri di liquidi al giorno. E questo ha fatto la differenza.
E il motivo di sostanza?
Questa è solo una mia opinione, ovviamente. Ho avuto l’impressione che fossero poco un gruppo, che fossero troppo individualisti. Raymond Lambert era una stella, ma non stava simpatico a tutti. Edouard Wyss-Dunant, il capo-spedizione, non aveva delle gran doti da leader. Andar forte sulle Alpi, in situazioni come quella, serve fino a un certo punto.
Voi, invece, avete scelto alpinisti che andavano maluccio.
Non dica stupidaggini, per favore! George Band e Michael Westmacott erano degli arrampicatori su roccia di prima forza. Tom Bourdillon aveva appena fatto una delle primissime salite – e la prima inglese – della via Bonatti al Grand Capucin. Certo, non era facile per i giovani arrampicatori di punta entrare nel giro. Due straordinari personaggi come Joe Brown e Don Whillans nel 1953 erano giovanissimi, non sarebbero potuti entrare nel gruppo.
Insomma, la cosa migliore di quella spedizione?
La vetta… ma no, l’amicizia. Sì, l’amicizia.
E la cosa migliore del dopo-spedizione?
L’interesse incredibile che la salita dell’Everest ha suscitato nel mondo, e dico proprio in tutto il mondo. Capisco l’entusiasmo a Londra, ad Auckland, e nei paesi alpini. Capisco le feste a Calcutta, a Delhi, a Kathmandu, a Karachi. Ma abbiamo avuto un’accoglienza incredibile anche al Cairo. Che diavolo ne sanno, dell’Everest, al Cairo?
Forse era la cosa giusta nel momento giusto…
In parte sì, senz’altro. Era finita la guerra, c’era bisogno di ideali diversi, di pace. Non dimenticherò mai l’accoglienza trionfale che abbiamo avuto a Mosca, nonostante la Cortina di Ferro e la Guerra Fredda.
Insomma, della spedizione vittoriosa all’Everest si è parlato più che non dei Poli, più che della conquista della Luna. Non è un po’ esagerato?
Forse, ma sono tutte mete simboliche, no? Pestare ghiaccio al Polo Nord, neve sull’Everest o sabbia sulla Luna non ha una grande importanza per sé, però significa qualcosa. Ma la spiegazione sta nell’informazione.
Che ai tempi della conquista dei Poli c’era poco?
Sì, e al momento di Armstrong sulla Luna c’era troppo. Ne hanno parlato tutti, ma solo per qualche mese. Invece nel 1953 la notizia della conquista dell’Everest poteva arrivare dovunque, ma c’erano abbastanza poche notizie per consentirle di restare importante per un po’.
Manca una cosa. Qual è il ricordo peggiore, che John Hunt ha di quella spedizione?
Lo vuole sapere a tutti i costi? Preferirei non parlarne. Abbiamo vinto, e complessivamente è stata un’esperienza eccezionale.
Un piccolo sforzo…
Ma si, un problema c’è stato, l’ho già detto. La pressione su Tenzing, il tentativo di contrapporlo a Hillary, a tutti noi. Per me era così importante quell’unità tra noi e gli sherpa. Posso dire una cosa un po’ grossa?
Prego.
Che questa collaborazione tra l’Est e l’Ovest è stata veramente importante. Non so se è stato capito come merita. A me, il fatto che un bianco e uno sherpa siano arrivati insieme sulla cima è sembrato (e sembra ancora) un messaggio di pace all’umanità.
Dopo la nostra chiacchierata del 1983 a Henley-on-Thames, ho incontrato solo una volta John Hunt. A Biella, durante il convegno di Mountain Wilderness nel 1987, era impegnato a sintetizzare in un documento le raccomandazioni ambientali in tema di alpinismo himalayano. L’ho interrotto un momento per portargli i saluti di Edmund Hillary, che avevo incontrato il giorno prima a Losanna, e lui mi ha quasi mandato al diavolo. Poi ha ricambiato il saluto e ha sorriso.
Nel 2005 George Band, l’alpinista della spedizione del 1953 che due anni dopo era arrivato in cima al Kangchenjunga, mi ha parlato con stima e grande affetto di Sir John. In quel momento, però, Hunt era morto da più di sei anni. Nelle sale della Royal Geographical Society, poco dopo, ho scoperto che il suo ritratto era esposto accanto a quelli di James Cook e di David Livingstone, tra i miti della geografia e dell’Impero.
L’ultimo “incontro” con John Hunt è avvenuto nel 2015, mentre lavoravo a Il gigante sconosciuto, il mio libro dedicato al Kangchenjunga. In un affascinante articolo dell’Himalayan Journal ho letto della straordinaria spedizione sul ghiacciaio di Zemu, sul versante orientale del Kangch compiuta da Hunt nel 1937 insieme alla moglie Joy, a Reginald Cooke ed alcuni degli sherpa più esperti di quegli anni.
Le avventure del team sul Nepal Peak, sul Sugarloaf e sullo Zemu Gap dimostrano che John Hunt era un alpinista con i fiocchi. E che, nelle discussioni su chi dovesse guidare la spedizione all’Everest, chi lo ha descritto come un militare ignorante e un burocrate ha fatto un errore colossale.
Stefano Ardito Incontri ad alta quota, Corbaccio, Milano 2017
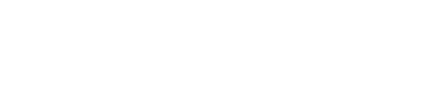

Commenti recenti