Dolomiti di Sesto, alba del 4 luglio 1915. Un uomo lascia un ripido canalone innevato e sale per una parete verticale, verso una cima che conosce molto bene. Sulla neve ha dovuto usare la piccozza, ora arrampica sulla roccia, un appiglio dopo l’altro. Si chiama Josef Innerkofler, ma in paese tutti lo chiamano Sepp, l’equivalente tedesco di Peppino.
La moglie Maria gli ha dato sette figli, ma due di loro sono morti ancora bambini. Alla fine di ottobre, se ci arriverà vivo, Sepp festeggerà i cinquant’anni. E’ un uomo di pace e un grande lavoratore, ma sa che quella scalata potrebbe costargli la vita. A tracolla, mentre sale verso la vetta del Paterno, Sepp Innerkofler ha un fucile. Al posto dei vestiti da montagna degli anni di pace indossa l’uniforme degli Standschützen della Val Pusteria. Nello zaino e nelle tasche ha una scorta di bombe a mano.
Sepp Innerkofler è nato in una famiglia semplice, ma di grande tradizione montanara. Negli anni, grazie al suo lavoro e alla sua abilità su roccia e ghiaccio, ha fatto carriera, diventando una guida alpina famosa, e un imprenditore del turismo.
Un percorso simile a quello seguito vent’anni prima da suo zio Michael, un oste della Valle di Landro che si è trasformato in uno straordinario alpinista, con all’attivo molte prime salite importanti, e che è morto nel 1888 sul ghiacciaio del Cristallo, quando un ponte di neve ha ceduto sotto al suo peso.
Anche Sepp Innerkofler ha alle spalle decine di belle ascensioni. La sua via nuova più nota, nell’estate del 1890, è la parete Nord della Cima Piccola. Un itinerario di quarto grado, che il giovane alpinista di Sesto inaugura insieme al cugino e collega Veit, e al cliente Hans Helversen. Lo ricordano anche una via sul versante meridionale della Cima Ovest (1899), e lo spigolo settentrionale del Paterno (1890), la via che affronta in condizioni ben diverse un mese e mezzo dopo lo scoppio della guerra tra l’Austria-Ungheria e l’Italia.
Da ragazzo, Sepp Innerkofler lavora come servo-pastore in un maso. Poi diventa dipendente di una segheria della valle, e dedica il suo tempo libero all’arrampicata e alla caccia. A 24 anni, nel 1889, ottiene la patente di guida alpina. E il nuovo mestiere diventa il fulcro della sua vita.
Grazie alla sua abilità in roccia, alla sua cortesia con i clienti, alle sue vie tracciate nel 1890 e diventate rapidamente famose, Sepp diventa in pochi anni la guida più richiesta dell’alta Val Pusteria. “Una di quelle guide” come scrive lo storico dell’alpinismo Antonio Berti “con cui gli alpinisti si legavano per l’onore di poter dire “sono stato con lui!””.
Nel 1895, insieme alla moglie Maria, Sepp Innerkofler prende in gestione il rifugio del Monte Elmo, belvedere sulle Dolomiti di Sesto. Tre anni dopo, nel 1898, ottiene dalla sezione di Niederdorf (Villabassa) del DÖAV, il Club Alpino austro-tedesco, la gestione della Dreizinnen Hütte, da cui si ammira un perfetto colpo d’occhio sulle Tre Cime. Da qui, in breve, si arriva agli attacchi delle vie di arrampicata.
Qualche anno dopo, l’infaticabile Sepp prende in gestione anche la Zsigmondy Hütte, ai piedi della Croda dei Toni. La gigantesca montagna che la gente di Sesto, che utilizza le vette a sud dell’abitato come una meridiana naturale, chiama da secoli Zwölfer, la Cima di Mezzogiorno.
Grazie ai suoi guadagni come guida e a quelli provenienti dalla gestione dei rifugi, Sepp costruisce a Sesto la Villa Innerkofler, una bella casa per la sua famiglia, con una dépendance dove ospita a pagamento i turisti. Nel 1908 inaugura l’albergo Dolomiten, in Val Fiscalina. E’ uno degli uomini più ricchi e stimati della valle, potrebbe iniziare a pensare alla pensione e ai nipoti. Invece arriva la guerra.
Dopo il 1866, come altri massicci dei Monti Pallidi, le Tre Cime di Lavaredo sono attraversate dal confine tra l’Impero di Austria-Ungheria e il Regno d’Italia. Dopo il conflitto che gli storici italiani chiamano Terza Guerra d’Indipendenza, e che per gli austriaci è il “fronte Sud” della guerra tra l’Impero e la Prussia, il confine torna sulla linea che ha separato per secoli la Repubblica di Venezia dal Tirolo, e dove sorgono ancora dei cippi in pietra del Settecento.
Per decenni, Innerkofler non ha problemi a traversare la Forcella Lavaredo per passare sul versante di Auronzo e salire le vie normali della Cima Grande, della Cima Ovest e della Cima Piccola. Anche dopo la prima salita della parete Nord della Piccola, con il cugino Veit e il Helversen, Sepp scende sul versante italiano, e rientra scavalcando la Forcella.
Negli ultimi mesi del 1914, e all’inizio del 1915, la gente della Val Pusteria non si preoccupa dei soldati italiani. Dopo lo scoppio della guerra con la Serbia e la Russia, e poi anche con la Francia, molti giovani delle valli tirolesi hanno vestito la divisa e sono dovuti partire per il fronte. Sepp Innerkofler, con i suoi quasi 50 anni, è troppo vecchio per essere chiamato alle armi.
Nella primavera del 1915 l’atmosfera cambia. Sui valichi e sulle creste, i militari in grigioverde sono armati e sempre più tesi, e non scherzano con i valligiani sudtirolesi che salgono dal versante di Sesto. In Valle di Landro e al Passo di Monte Croce Comelico, i genieri di Francesco Giuseppe piazzano cariche di esplosivo accanto ai ponti e alle strade.
Nelle prime settimane di maggio, tutti sanno che la guerra sta arrivando. La frontiera è chiusa, strade e ponti sono stati fatti saltare. Ma gli abitanti di Sesto e dei paesi vicini sanno che, dalla valle del Piave e da Auronzo, i reparti in grigioverde stanno salendo verso il confine.
Sepp Innerkofler è un uomo di pace, ma è anche un patriota tirolese. Il 19 maggio, quattro giorni prima della dichiarazione di guerra, si arruola volontario negli Standschützen, insieme a due fratelli e al figlio primogenito. La sua esperienza di alpinista e di guida dovrebbe essere preziosa. Ma il 21 maggio, quando Sepp propone di occupare il Paterno, una cima di 2744 metri che si alza di fronte alle Tre Cime, il capitano Jaeschke, il suo superiore, gli risponde di no.
Il 25 maggio, dal Paterno, Sepp Innerkofler vede arrivare le cannonate italiane che radono al suolo il rifugio dove ha lavorato per diciassette anni. “Al quinto colpo la mia casa di montagna si incendia. Mentre scrivo qui sul Paterno brucia il rifugio giù in fondo, e questo rogo tra i monti mi fa sentire impotente” scrive nel suo diario. “Adesso, Dio sia lodato, c’è il sole. E tutto questo mi appare più interessante che pauroso e terribile”.
Il 26 maggio, contro il parere di Innerkofler e di un’altra guida, Hans Forcher, il capitano Jaeschke ordina agli Standschützen di Sesto di abbandonare il Paterno. Tre giorni dopo, un reparto di alpini conquista i 2744 metri della cima. Se lassù dovessero arrivare dei fucili di precisione o dei cannoni, i soldati imperiali trincerati accanto ai resti della Dreizinnen Hütte diventeranno facili bersagli.
Innerkofler, Forcher e le altre guide della “Pattuglia volante”, in quei giorni, effettuano diciassette uscite esplorative. Uno di loro, che di cognome fa Piller, è originario di Sappada, ed è quindi cittadino italiano. Come Cesare Battisti, un suddito di Francesco Giuseppe che si è arruolato volontario negli alpini, sa bene che in caso di cattura, per lui, ci sarà il plotone di esecuzione.
A giugno gli italiani passano decisamente all’offensiva. Sulla vetta e sui contrafforti del Paterno costruiscono postazioni che sfruttano le spaccature della roccia, rinforzate da muretti di pietre. Sulla Forcella del Camoscio, poco sotto la cima, piazzano un cannone che minaccia le linee di rifornimento nemiche.
Finalmente, i comandanti austro-ungarici si rendono conto che abbandonare quella cima agli alpini è stato un errore. Nei primi giorni di luglio il capitano von Wellean, che ha sostituito Jaeschke, ordina a Innerkofler, a Forcher e ai loro uomini di riconquistare il Paterno. Tutti sanno che sarà un assalto disperato, se non suicida.
Alle quattro del mattino del 4 luglio, quando il cielo intorno alle Tre Cime schiarisce, i cannoni e le mitragliatrici del Sasso di Sesto e della Torre di Toblino sparano sulle postazioni italiane del Paterno. Ma una preparazione come questa, necessaria nei teatri di guerra pianeggianti, toglie ai reparti d’assalto l’arma fondamentale, la sorpresa.
Prima di scavalcare i reticolati austriaci, Sepp ordina a suo figlio Gottfried di non seguirlo. “Per la mamma sarà già abbastanza dover piangere uno di noi” mormora mentre lo abbraccia per l’ultima volta. Poi, mentre il tiro delle batterie austriache costringe gli alpini sulla cima a tenersi al riparo, gli uomini della “Pattuglia volante” salgono in direzione del Paterno.
Aggirano il torrione del Frankfurter Würst, salgono per nevai al riparo delle rocce. Poi affrontano il canalone innevato che sale alla Forcella del Camoscio. Le guide, in testa al gruppo, scavano gradini con la piccozza. Sei uomini, al comando di Sepp, piegano a destra per un camino verticale. Le difficoltà sono di terzo grado, non estreme. Sopra alle rocce, però, attendono i fucili degli alpini.
Quando sbuca in cresta, Sepp ordina ai compagni di fermarsi, e prosegue da solo. Si ferma su un terrazzo innevato, toglie la sicura a una bomba a mano, la lancia verso gli alpini sulla cima. Quella prima bomba non scoppia, e la guida diventata soldato ne lancia una seconda, e poi una terza e una quarta. Solo una di queste, secondo le ricostruzioni, esplode. E colpisce con schegge di metallo e frammenti di roccia gli italiani.
Dopo qualche minuto, dalle postazioni austro-ungariche, ufficiali e soldati assistono alla morte di Sepp Innerkofler. Cade all’improvviso all’indietro, scivo nella neve, si ferma all’uscita del camino, resta immobile. Che sia morto non c’è dubbio. Quel che è davvero successo, però, resta a lungo un mistero.
La versione ufficiale austriaca racconta che Sepp viene colpito alla fronte, poi precipita verso il camino. Secondo la versione italiana, diffusa dagli scritti di Antonio Berti, l’eroe della giornata è l’alpino Pietro De Luca del battaglione Val Piave. Dopo essere stato ferito dalla bomba a mano di Innerkofler, De Luca si alza con una pietra tra le mani, la getta sul nemico gridando “no te vol andar via?”. Quel colpo fa perdere l’equilibrio a Sepp, e lo fa cadere e morire.
Una terza versione dei fatti, la più plausibile, si diffonde subito tra i militari austro-ungarici e i valligiani di Sesto. Ma non può essere raccontata in tempo di guerra, perché il disfattismo è punito con la fucilazione. Secondo questa versione, a uccidere il grande Sepp Innerkofler è quello che oggi chiamiamo fuoco amico.
Nel momento in cui la guida si alza per lanciare le sue bombe a mano sulla vetta, secondo numerosi testimoni, la mitragliatrice austriaca sulla Torre di Toblin apre il fuoco. Secondo il figlio minore, che osserva dal Sasso di Sesto, prima di piegarsi all’indietro e cadere, Sepp si gira per un attimo verso i suoi, come per rimproverarli, o per chiedere perché.
“La mitragliatrice fu subito messa a tacere, ma era troppo tardi” scriverà nel 1937 e poi ancora nel 1975o Sepp Innerkofler junior, il più giovane figlio della guida. “Alla seconda esumazione di mio padre nel cimitero di Sesto ero presente, e vidi che la testa era stata perforata in diagonale, dalla fronte verso l’occipite. Penso che mio padre si accorse che gli sparavano addosso da dietro e che si voltò”.
Poi, sul Paterno torna il silenzio. Dopo aver visto morire il grande Innerkofler, gli altri uomini della “Pattuglia volante” scivolano a valle sulla neve del canalone verso le posizioni di partenza. L’indomani, nonostante le raffiche delle mitragliatrici austriache, gli alpini del Val Piave si calano con le corde, recuperano il corpo di Sepp, scoprono il nome del loro nemico inciso sul manico della piccozza. Quando lo seppelliscono in una spaccatura della roccia, piazzano accanto a quella semplice tomba una targa, “Giuseppe Innerkofler guida”.
Il 9 luglio l’arciduca Eugenio d’Asburgo assegna alla memoria di Sepp Innerkofler, la medaglia d’oro al valor militare. Due anni e mezzo più tardi, dopo la rotta di Caporetto, gli alpini e i fanti italiani abbandonano le Dolomiti. Nell’estate del 1918, quando le rocce del Paterno sono finalmente libere dalla neve, gli Schützen e i civili di Sesto tornano sulla cima, recuperano il corpo, lo seppelliscono nel cimitero del paese.
La foto in bianco e nero della bara mentre viene calata di peso, tra decine di uomini aggrappati a corde e a scale, lungo la parete verticale tra la Forcella del Camoscio e la cima, è una delle più celebri e tristi della Grande Guerra sulle Alpi.
Dopo la battaglia del 4 luglio, austro-ungarici e italiani continuano a scontrarsi sul Paterno e le Tre Cime. Sulla Cima Grande di Lavaredo, 2999 metri, viene issato un riflettore che aiuta gli artiglieri e i mitraglieri in grigioverde a sparare. Il cappellano militare Pietro Zangrando sale lassù a celebrare una Messa.
La sera del 14 agosto tre colonne italiane, appoggiate dall’artiglieria e dal riflettore, avanzano verso Forcella Toblìn e i resti della Dreizinnen Hütte, ma il fuoco degli austro-ungarici li blocca. Il 17, i battaglioni alpini Val Piave e Cadore occupano i ruderi del rifugio e il vicino Sasso di Sesto, ma non riescono a scacciare i difensori austriaci dalla Torre di Toblìn, trasformata in un groviera di postazioni e di scale.
Nei mesi e negli anni successivi, il fronte intorno alle Tre Cime non si sposta. Gli italiani, per rifornire le loro postazioni avanzate, scavano nelle rocce del Paterno un sentiero che passa a poche decine di metri dal punto dov’è caduto Innerkofler, e che nell’ultimo tratto è in galleria. Dalle loro postazioni, gli uomini in grigioverde vedono la Val Pusteria, e i ghiacciai delle Vedrette di Ries e degli Alti Tauri. Dobbiaco, San Candido, Brunico e le strade verso il Brennero e Lienz, però, restano un miraggio proibito.
Prima dell’attacco contro la Forcella di Toblìn, per disturbare i rifornimenti del nemico, e aprire un varco per un’avanzata verso la Val Pusteria, le artiglierie italiane devastano l’abitato di Sesto. Il 31 luglio, dopo che l’ennesimo reparto imperiale, ben visibile agli osservatori italiani, è entrato marciando in paese, una granata colpisce la casa del sindaco Johann Kiniger, uccidendo la figlia e ferendo gravemente la moglie. L’indomani, un altro colpo di cannone esplode sulla terrazza dell’Hotel Post, uccidendo sette persone e ferendone molte altre.
I comandi austro-ungarici, con colpevole ritardo, ordinano lo sgombero delle circa mille persone – donne, bambini, anziani – ancora presenti in paese. Il 12 agosto, decine di cannonate italiane sparate dal Passo di Monte Croce Comelico, e poi gli incendi causati dai colpi, distruggono venti case, la chiesa e la scuola.
“Le prime bombe incendiarie colpirono la chiesa. Il fuoco si propagò rapidamente lungo il tetto. Poi un suono stridulo e lamentoso, precipitavano al suolo le campane. Per tutta la notte, nel cielo, ha divampato il bagliore rosso sangue del paese in fiamme” scriverà il cappellano militare Reinhard Rainalter.
Oggi, nelle belle giornate d’estate, le trincee e le gallerie del Paterno vedono passare centinaia di escursionisti. I muri di cemento dei tunnel, le targhe lasciate dai reparti, i resti dei reticolati, le trincee, l’immagine dolente del Cristo che campeggia sulla cima non lasciano dubbi sul fatto che questo sia stato un luogo di sofferenza e di morte.
Un medaglione ricorda Sepp Innerkofler accanto al rifugio di cui è stato per diciassette anni il gestore, un’altra targa conserva il suo nome sulla cima, croci e lapidi ricordano i nomi di altri caduti. Le ferrate e i tunnel, dopo essere stati messi in sicurezza con la collaborazione delle guide alpine di Auronzo e di Sesto, vengono inaugurati nel 1975 dalla sezione di Padova del CAI.
Nei primi anni del nuovo millennio, per ridurre gli ingorghi, sul salto sotto alla cima del Paterno, dove la foto di cui abbiamo raccontato ricorda il passaggio della bara di Sepp Innerkofler, le ferrate diventano due, una per la salita e l’altra per la discesa.
Al termine della Grande Guerra, mentre i rifugi del DÖAV rimasti intatti passano alle sezioni del CAI, della Dreizinnen Hütte resta poco. Un privato di Sesto erige al suo posto una piccola struttura, che gli viene requisita poco dopo.
Poi, tra il 1935 e il 1936, le sezioni di Bolzano e Padova del CAI costruiscono un nuovo grande rifugio. Per volere del Comitato Centrale del Club, viene intitolato al bergamasco Antonio Locatelli, accademico del CAI, presidente della sezione di Bergamo, pilota decorato con tre medaglie d’oro e fascista della prima ora.
Locatelli è anche un uomo di esplorazione e avventura, che nell’estate australe del 1919 compie la prima trasvolata delle Ande dall’Argentina al Cile, ed è il primo a osservare dal cielo l’Aconcagua, la cima più alta delle Americhe. Viene ucciso nel 1936, durante l’invasione italiana dell’Etiopia, da una banda di ribelli somali.
Negli anni Trenta, e nel secondo dopoguerra, quel rifugio dedicato a un italiano legato al fascismo non va giù alla gente del Sudtirolo. A smussare i potenziali conflitti, come in decine di casi analoghi, provvede il fatto che le pubblicazioni in lingua tedesca chiamano il rifugio con il vecchio nome, Dreizinnen Hütte, e quelle italiane parlano solo di rifugio Locatelli.
Per decenni, i due nomi, e le due letture della storia, coesistono senza doversi confrontare. “A far infuriare la gente della Val Pusteria, ben prima del cambiamento di nome del rifugio, sono state le cannonate italiane che lo hanno raso al suolo nel 1915” mi racconta un giorno Hugo Reider, avvocato nato in Val Pusteria e residente a Bolzano, che in estate lascia il tribunale e la toga per gestire il rifugio.
Nel 2008, a novant’anni dalla fine della guerra, Il rifugio Locatelli/Dreizinnen Hütte viene dedicato anche a Sepp Innerkofler. Trecento metri di dislivello più in alto, un nuovo sentiero attrezzato tra la Forcella del Camoscio e il rifugio Pian di Cengia viene intitolato a Innerkofler e a Pietro De Luca, l’alpino del battaglione Val Piave che secondo la tradizione lo ha ucciso. Una soluzione che aiuta a consolidare la pace.
Testo tratto da Alpi di Guerra Alpi di Pace di Stefano Ardito, Corbaccio 2014, seconda edizione 2024
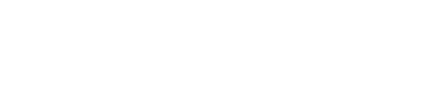

Bel racconto, complimenti